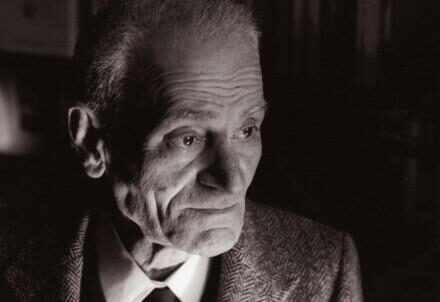Si litiga sul lavoro, si litiga. Forse perché c’è di mezzo, sì, il vile denaro, ma anche e soprattutto il desiderio di sé, di affermarsi, di essere riconosciuti da noi stessi e dal nostro prossimo: il desiderio, insomma, di valere. Ma che succede quando a litigare per lavoro sono due poeti umanissimi, sensibili e amici da ormai vent’anni come lo sono Caproni e Betocchi nell’estate del ’55? È una delle delizie che possiamo leggere scorrendo per l’ennesima volta il bellissimo epistolario Una poesia indimenticabile. Lettere 1936-1986, pubblicato già da qualche anno a cura di Daniele Santero (Maria Pacini Fazzi 2007, 26 euro).
Caproni e Betocchi si conoscono dal ’36, da quando cioè il giovane poeta livornese invia il suo primo libretto Come un’allegoria al già noto Betocchi, ricevendone una risposta inattesa e grata. A questa primo invio ne seguono altri, sempre più fitti nella frequenza e liberi e ricchi nei contenuti, via via che avanza il riconoscersi reciproco, la scoperta di un sentire comune: dello scrivere, e perciò del vivere. Arriviamo così al 1954, quando Betocchi – che al tempo ha già lasciato il lavoro di geometra nei cantieri e lavora per l’editore Enrico Vallecchi – propone all’amico Giorgio di pubblicare presso di lui un libro che faccia definitivamente uscire il suo nome dal guscio: è l’inizio della storia de Il passaggio di Enea, il primo libro capitale di Caproni.
Preoccupato della propria umoralità, e che questa lasci il libro «sempre quasi pronto e mai pronto del tutto (Caproni a Betocchi, 22 luglio 1954)», l’autore chiede a Betocchi di fissargli una scadenza; scadenza che rispetterà, con qualche giorno di ritardo, spedendo il libro il 9 settembre. Ma il lavoro è lavoro, si sa, e le cose non sempre vanno come dovrebbero o potrebbero. Così il libro resta in attesa, in un’attesa che si fa pian piano più snervante e fiacca il già mutevole umore del suo autore. E non migliorano le cose le offerte di pubblicazione ricevute da altri – come Vittorio Sereni – che gli provocano anzi ancora più patemi, stringendolo tra il desiderio di vedere nascere la sua opera e la fedeltà alla parola data, più che a Vallecchi, al caro Betocchi.
Finché, come accade spesso a quegli uomini miti da lui descritti in All alone, uno dei poemetti che compongono il libro nascente, Caproni sbotta e matura la decisione di chiedere indietro il suo manoscritto. Lo scrive, e non è la prima volta, nella lettera del 25 giugno 1955, cui Betocchi risponde con una missiva purtroppo perduta in cui difende le ragioni del proprio datore di lavoro. Ma sarà il caldo, siamo ormai in luglio, sarà quel verme del sospetto che – complice il dolore – s’insinua a volte anche nei rapporti più solidi e sicuri, Caproni assume le parole di Betocchi come una difesa d’ufficio e proprio in quanto amico non glielo manda a dire: «Sono addolorato per quanto mi dici della tua mamma, e ti fo un augurio grosso come il mio cuore, che sai quanto vicino al tuo. E mi dispiace per il resto che mi dici, perché (anche) il saperti così con questi calori mi fa immaginare le tue tristezze. E mi dispiace, anche, che tu abbia speso un’intera lettera a giustificare “una casa editrice”, con tutte ottime ragioni che non diminuiscono d’un millimetro la mia amarezza e, ormai, il mio disamore (Caproni a Betocchi, 13 luglio 1955)».
La vicenda del libro – che uscirà infine nel giugno del 1956 – sarà ancora lunga e mentre Betocchi avrà tempo di pentirsi per aver suggerito a Caproni di non portarlo altrove, così Caproni avrà modo di rimarcare come benché gli anni passino i due amici restino «sempre dei “provvisori” in fatto d’impieghi […] avventizi sino alla fine, sempre col batticuore per i nostri figli (Caproni a Betocchi, 13 maggio 1956)».
Quel che resta centrale, tuttavia, del dialogo tra i due e della vicenda che racconta, è la ragione ultima con cui Betocchi spiega all’amico la sua difesa dell’editore: «Vorrei dirti, caro Giorgio, che noi non siamo responsabili della condizione sociale nella quale viviamo, ma siamo responsabili verso la nostra coscienza del nostro umano contegno. […] A differenza di molti, e qualunque fosse il mio giudizio generale sul rapporto di lavoro al quale ero obbligato, ho sempre rispettato chi mi ha dato il pane, l’ho compatito, direi, nel suo egoismo, ho cercato di comprenderlo nelle sue necessità e difficoltà. […] Tu hai ragione, d’accordo. Ma che misera soddisfazione aver ragione, che soddisfazione da intellettuali! Tu sei un poeta, e tu sai che la tua ragione è comprendere anche chi non ne ha, ovvero non ha che quella che gli assegna l’oscuro dominio delle cose, che ci trascina tutti: comprenderli più che essi stessi non si comprendano, e fare in modo che siano, parzialmente come sempre, i veicoli di quella ragione che tu difendi (Carlo Betocchi a Giorgio Caproni, 18 luglio 1955)».
La ragione ultima di un’adesione alle cose e a ciò cui le cose portano, di una gratitudine per chi dà il pane che rende corposa e reale la gratitudine per l’essere. Quella ragione che – a libro finalmente in bozza – Betocchi opporrà alle nuove remore caproniane, spingendo l’amico all’azione dovuta, sicuro in pari modo della sua ultima incognita quanto della sua necessità: «Urge che tu restituisca le bozze del libro per poterlo mandare anche al Premio Marzotto. Giorgio, devi farlo, e provvedere senza esitazioni, se vuoi conservare la mia amicizia. Non sei tu solo a decidere, c’è una ragione delle cose che non dipende da noi. Tu non sei un poeta voluto, ma un poeta naturale, autentico. Quindi non sai niente di te, e puoi giudicare solo fino a un certo punto, cioè facendo. […] Il dado è tratto non è una smargiassata, è una parola di vita. Senza questa parola non c’è né inferno né paradiso: e senza inferno e paradiso non ci sono poeti (Betocchi a Caproni, 18 giugno 1956)».